Racconti delle strade dei mondi
Jonathan Livingston e il Vangelo
Strade Nascoste – Racconti
Inferno e Paradiso (racconto)
Lontano dalla Terra (racconto)
La fine di ogni cosa (racconto)
L’Ultimo Baluardo (racconto)
|
By M.T., on Ottobre 20th, 2024   Defiant conferma le impressioni che avevo avuto con Cytonic: la saga sci-fi di Brandon Sanderson è andata in calare. Con Skyward e Starsight, i primi due volumi della serie, la storia si era mantenuta su un buon livello, risultando coinvolgente e convincente, mentre con il terzo, il già citato Cytonic, si era cominciato ad avvertire una certa mancanza di mordente. Forse era stato l’immettere una sorta di giocare ai pirati di Spensa, forse era stata la specie di ricerca alla Indiana Jones (qualcuno potrà dissentire su quanto scrivo, ma tale è l’impressione che ho avuto leggendo Cytonic), ma ho trovato il tutto un poco fuori posto con l’ambientazione fantascientifica letta fino a quel punto. Sia chiaro: la fantascienza realizzata da Sanderson non è niente di complesso (nulla a che vedere con il mondo e la storia di Dune di Herbert), ma è godibile, almeno fino al terzo romanzo. Continua a esserlo anche con esso e dopo di esso, ma non è più la stessa cosa dell’inizio, non sorprende e non prende più allo stesso modo; è possibile che ciò dipenda dal fatto che la serie è indirizzata a un pubblico young adult e visto che ormai non ho più quell’età da un pezzo (gli anni si sono accumulati e così pure le letture fatte), la percezione e l’impressione sull’opera possono essere diverse (potrei dissentire su tale ipotesi, dato che i primi due romanzi mi erano piaciuti e mi avevano convinto e non è che ero adolescente quando li ho letti). Defiant conferma le impressioni che avevo avuto con Cytonic: la saga sci-fi di Brandon Sanderson è andata in calare. Con Skyward e Starsight, i primi due volumi della serie, la storia si era mantenuta su un buon livello, risultando coinvolgente e convincente, mentre con il terzo, il già citato Cytonic, si era cominciato ad avvertire una certa mancanza di mordente. Forse era stato l’immettere una sorta di giocare ai pirati di Spensa, forse era stata la specie di ricerca alla Indiana Jones (qualcuno potrà dissentire su quanto scrivo, ma tale è l’impressione che ho avuto leggendo Cytonic), ma ho trovato il tutto un poco fuori posto con l’ambientazione fantascientifica letta fino a quel punto. Sia chiaro: la fantascienza realizzata da Sanderson non è niente di complesso (nulla a che vedere con il mondo e la storia di Dune di Herbert), ma è godibile, almeno fino al terzo romanzo. Continua a esserlo anche con esso e dopo di esso, ma non è più la stessa cosa dell’inizio, non sorprende e non prende più allo stesso modo; è possibile che ciò dipenda dal fatto che la serie è indirizzata a un pubblico young adult e visto che ormai non ho più quell’età da un pezzo (gli anni si sono accumulati e così pure le letture fatte), la percezione e l’impressione sull’opera possono essere diverse (potrei dissentire su tale ipotesi, dato che i primi due romanzi mi erano piaciuti e mi avevano convinto e non è che ero adolescente quando li ho letti).
Una cosa però va detta: uno dei punti deboli più forti di Defiant è che si fa sentire con forza lo young adult, soprattuttto nella parte romance, quando Spensa comincia a partire per la tangente pensando a quanto è bello, quant’è figo il suo amato Jorgen. Niente in contrario con le storie d’amore: quella di Vin ed Elend nella saga di Mistborn era fatta bene. Quello che non va bene è lo scadere negli aspetti più negativi dello young adult, cosa che da Sanderson non si accetta, perché lo scrittore ha dimostrato cosa sa fare. Forse dipende dalle direttive editoriali, forse si è voluto realizzare qualcosa più per i giovani, dando insegnamenti come il non poter fare tutto da soli, contare sull’aiuto degli altri, fare parte di un gruppo così da non essere soli perché se si è soli si fa una brutta fine (questa è la lezione che si apprende mettendo a confronto Spensa e Brade) ma da un autore come Sanderson ci si aspetta altro.
Altro aspetto penalizzante del romanzo è il che vada tutto bene, non ci siano vittime. Se da un lato è comprensibile che si cerchi un modo differente di battere la Superiorità evitando di causare un gran numero di vittime, è però anche vero che è poco verosimile che questo accada realmente. Se fosse stato così fin da subito, forse la cosa si sarebbe accettata di più, ma è stato il cambiamento fatto durante il corso dell’opera che invece lascia un po’ perplessi; in Skyward, tanti piloti umani vengono uccisi, la stessa Spensa vede morire dei suoi compagni di squadriglia, mentre in Defiant solo uno dei suoi amici rimane ferito (perdita di un braccio, rimpiazzato da uno arteficiale che non fa risentire dell’accaduto). Sì, verso la fine c’è un sacrificio nella battaglia decisiva (come spesso accade in una certa tipologia di storie), ma nulla di più. Sembra che alla fine tutto vada per il meglio, con tutti che si ritrovano a tarallucci e vino.
Quello che però più penalizza la storia, almeno per quanto pubblicato in Italia, rendendola meno comprensibile, è il fatto di avere a che fare con eventi di cui non si è letto nulla; ci si ritrova all’improvviso a sapere di Jorgen che ha salvato Nonnina e Cobb dopo che erano rimasti bloccati in una trappola citonica a seguito di un iperbalzo. Ci si trova davanti all’alleanza creatasi tra umani, kitsen e UrDail pronta opporsi e ribaltare la Superiorità. Ci si ritrova a sapere che i citonici kitsen sono stati liberati dalla loro prigionia e ora sono ben lieti di combattere contro la Superiorità. Tutti eventi probabilmente narrati in Skyward Flight (libro integratico di Cytonic), come si può intuire dalle parole di Sanderson nei ringraziamenti finali in Defiant (sarà tradotto in italiano?)
Come in altre opere di Sanderson ci saranno sorprese, non tutto apparirà come si credeva, ci saranno battaglie, uno scontro risolutivo epico, Spensa avrà la resa dei conti con Brade, si scoprirà che ci sono tante razze di lumache con diversi poteri, la natura degli Eradicatori verrà approfondita (era già stato rivelata in Cytonic), ma ci sono anche elementi inutili per la storia di cui si poteva fare a meno (che senso ha ricostruire il caccia che un tempo ospitava M-Bot se poi non lo si utilizza e viene accantonato come si fa con l’involucro di un cioccolatino?).
Per quanto godibile, Defiant è un po’ troppo semplice, lineare e anche prevedibile, ma soprattutto è troppo young adult. Forse ci si aspetta sempre troppo da Sanderson visto quello che ha saputo dimostrare e questa è la ragione per cui si è così critichi con questo romanzo, ma con Defiant si poteva fare di meglio.
By M.T., on Ottobre 13th, 2024   The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes è la storia di due adolescenti, Tono Kaoru e Hanashiro Anzu, che s’incontrano in un giorno di pioggia alla fermata del treno; non avendo l’ombrello, il ragazzo dà alla ragazza l’ombrello perché vede che lei è senza e tiene ben stretta una borsa per non farla bagnare, segno che per lei è importante. The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes è la storia di due adolescenti, Tono Kaoru e Hanashiro Anzu, che s’incontrano in un giorno di pioggia alla fermata del treno; non avendo l’ombrello, il ragazzo dà alla ragazza l’ombrello perché vede che lei è senza e tiene ben stretta una borsa per non farla bagnare, segno che per lei è importante.
Come scopriranno poco dopo, sono nella stessa classe a scuola; Hanashiro praticamente non lega con gli altri compagni (anzi, ci litiga e viene pure alle mani), tranne con Tono, con cui sembra essere entrata subito in sintonia, forse perché hanno entrambi problemi con i genitori: lei vive da sola perché i suoi l’hanno mandata lontano da casa perché vuole seguire le orme del nonno mangaka (che hanno sempre considerato un peso e un fallito), lui vive con un padre alcolizzato dopo che la madre se n’è andata causa la scomparsa della sorella minore. La morte della sorellina ha segnato profondamente Tono, cambiandone il carattere e lasciando in lui una profonda ferita; è convinto che se la sorella non se ne fosse andata, la famiglia non si sarebbe sfasciata.
Le cose sembra che possano cambiare quando una sera, scappando di casa dopo che il padre ubriaco l’ha aggredito, Tono finisce per caso per trovare il Tunnel di Urashima capace, secondo una leggenda metropolitana, d’esaudire qualsiasi desiderio. Mentre lo esplora, trova uno dei sandali di Karen, la sorella, e subito dopo il pappagallino che avevano da piccoli, vivo e vegeto, quando ormai invece nella realtàè morto da tempo. Altra cosa che scopre una volta uscito dal tunnel è che è trascorso una settimana di tempo, mentre per lui sono passati pochi minuti.
Deciso ad approfondire la cosa, decide di ritornarci e a sua insaputa, viene seguito da Hanashiro. I due decidono di collaborare per venire a capo del segreto del tunnel e scoprire se per davvero può esaudire i loro desideri. La ragazza, durante le loro prove, ritroverà le tavole di un manga che aveva disegnato, e vuole esprimere il desiderio di diventare una mangaka affermata, dato che le possibilità per farcela sono poco e ci vuole un talento particolare per avere successo, cosa che lei non ritiene di avere.
Tono, dopo aver letto il suo lavoro, la incoraggia e lei decide d’inviare la sua opera a una casa editrice; con sua sorpresa, viene accettata, ma lei ritiene di non avere ancora successo e per questo decide di andare assieme al ragazzo fino in fondo al tunnel, come si erano promessi di fare.
Tono però non mantiene la promessa perché ha capito due cose: uno, che Hanashiro non ha biosgno del tunnel perché possiede già talento per avere successo; due, che il tunnel non esaudisce tutti i desideri, ma fa rriavere ciò che si è perso. Da solo entra nel tunnel, deciso ad arrivare in fondo al tunnell per riavere la sorella, anche se per farlo nel mondo reale passeranno degli anni.
Hanashiro, anche se sconvolta e staziata dal dolore di non poter rivedere Tono di cui si è innamorata, segue le ultime parole dell’ultima mail inviata dal ragazzo, e diventata una mangaka apprezzata. Tono, dal canto suo, riesce a ritrovare la sorella e mentre è assieme a lei nella loro vecchia casa, ritrova il cellulare che aveva gettato e legge le mail che Hanashiro gli ha inviato aspettandolo per anni. Tono capisce che entrando nel tunnel ha perso qualcos’altro e, incoraggiato dalla sorella, torna indietro.
Hanshiro ormai è una donna, ma quando rivede Tono, è come se il tempo non fosse mai passato e i due si baciano.
Cosa dire di The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes? Un buon film, che come atmosfere ricorda quelle di Makoto Shinkai (vedere Your name): sognanti, un po’ tristi, che parlano di cose perdute, persone che si allontanano e a volte si ritrovano. Tomohisa Taguchi segue un po’ le tracce di Shinkai, discostandosi dalle atmosfere del manga (almeno questo è quello che si capisce leggendo altre recensioni) e prendendo un’altra direzione dalla versione cartcea (la storia si focalizza solo sui due ragazzi, che appaiono più chiusi e “cupi”). Lo sviluppo del tema amoroso e del capire cosa è importante e di come alle volte si perda di vista ciò che conta inseguendo sogni impossibili, non sarà dei più originali (si è visto tante volte in tante forme diverse), ma svolge il suo compito di creare una storia che prenda lo spettatore e lo porti fino alla fine; il finale può sembrare un po’ affrettato e scontato, ma serve per discostarsi da certe atmosfere tristi(certo, sarebbe stato più interessante mostrare una Hanshiro più adulta che si domanda se Tono sta ancora camminando nel tunnnel, mostarndo lui che ancora insegue il suo sogno e far finire così il film, ma queste sono solo disquisizioni inutili). The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes è un buon film, ma non sarà annoverato tra quelli memorabili.
By M.T., on Ottobre 6th, 2024   Josée, la tigre e i pesci è un bel film d’animazione di Kotaro Tamura, magari non proprio il massimo dell’originalità, che in qualche modo può ricordare La forma della voce (si parla di disabilità), ma è una pellicola interessante, impegnata, con una buona regia, una bella fotografia, una trama ben sviluppata e personaggi approfonditi, specie in quello di Josée (si fa chiamare così per via della protagonista del suo libro preferito, ma in realtà il suo vero nome è Kumiko Yamamura). Josée, la tigre e i pesci è un bel film d’animazione di Kotaro Tamura, magari non proprio il massimo dell’originalità, che in qualche modo può ricordare La forma della voce (si parla di disabilità), ma è una pellicola interessante, impegnata, con una buona regia, una bella fotografia, una trama ben sviluppata e personaggi approfonditi, specie in quello di Josée (si fa chiamare così per via della protagonista del suo libro preferito, ma in realtà il suo vero nome è Kumiko Yamamura).
Josée è giovane donna disabile (è su una carrozzina a rotelle) e vive con la nonna iperprotettiva (i genitori sono morti da tempo); sa ben poco del mondo esterno e crede che tutto fuori di casa sia pericoloso e pieno di bestie spaventose (una delle frasi che dice è “ci sono tigri ovunque” e si capisce così in parte la ragione del titolo). Un giorno viene involontariamente salvata da uno studente universitario,Tsuneo Suzukawa, appassionato d’immersioni, il cui sogno è andare a studiare in Messico per osservare un pesce raro. La nonna, per ringraziarlo, gli offre un lavoro: occuparsi delle esigenze della nipote.
All’inizio il rapporto tra i due è difficile: Josée gli assegna da fare le mansioni più strane e inutili, lo tiranneggia, al punto che Tsuneo pensa di rinunciare al lavoro. Ma lentamente i due cominciano a comprendersi; Tsuneo le fa conoscere il mondo esterno, nonostante il divieto della nonna di uscire di casa (un divieto che però è solo di facciata, perché la nonna è felice che la nipote cominci ad aprirsi e a crescere). E mentre Tsuneo le fa rivedere il mare così da rispondere alla domanda fattale dal padre su quale sapore avesse il mare e le fa conoscere altre persone, rimane colpito dalla bravura della ragazza nel disegnare e nella passione che mette in quello che fa. Josée, dal canto suo, grazie anche all’amicizia di Kana, la bibliotecaria che ha conosciuto con le uscite di Tsuneo, si apre agli altri e scopre di voler pubblicare un libro illustrato per bambini.
Tutto sembra procedere per il meglio, ma la morte della nonna cambia le cose: Josée, essendo disabile, subisce pressioni dai servizi sociali e si scontra con una realtà diversa dai sogni che ha. C’è una sorta di frattura con Tsuneo e i due si allontanano, almeno fino a quando lui ha un incidente e rischia di non riuscire più ad andare in Messico; scoraggiato, Tsuneo pensa di rinunciare, ma la forza d’animo di Josée gli fa ritrovare il coraggio di non mollare. Ognuno dei due alla fine riesce a trovare la propria strada e a dichiarare i sentimenti che prova per l’altro.
Certo, Josée, la tigre e i pesci non è un film perfetto, ci sono delle forzature e delle coincidenze che fanno alzare gli occhi al cielo, come se tutto fosse guidato per arrivare a un determinato punto, ma nel complesso è un film godibile, che mostra come affrontare e superare le difficoltà, come comprendere e conoscere meglio l’altro. Forse il finale è la parte debole del film, spinto verso l’happy end, ma la critica non è tanto per la scelta che viene fatta, ma per come viene realizzata; ciò non toglie validità a Josée, la tigre e i pesci, uno di quei film che ogni tanto occorre vedere per capire che nonostante le brutture che ci sono nel mondo, c’è qualcosa per cui vale la pena andare avanti.
By M.T., on Settembre 29th, 2024   Matrix Resurrections: perché è stato realizzato? Matrix Resurrections: perché è stato realizzato?
In realtà lo si sa (per fare soldi, anche se l’intento, visti i risultati ottenuti, non è stato raggiunto), ma ce n’era davvero bisogno? A mio avviso, no.
Nel film si percepisce una certa stanchezza (e pure una certa svogliatezza) e si può dire che non si prende neanche tanto sul serio, anzi, ci sono dei momenti in cui si fa parodia da solo, ma questo non basta certo a risollevare le sue sorti. Si rivedono i due attori protagonisti Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, oltre a Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson e Daniel Bernhardt che interpretano gli stessi personaggi dei film precedenti, mentre spicca l’assenza di Laurence Fishburne; nonostante un cast di buon livello e già collaudato per questa serie, Matrix Resurrections non decolla mai e il motivo è presto detto: perché il mondo di Matrix aveva già detto tutto quello che c’era da dire.
Sinceramente, già con il primo film ci si poteva fermare: con qualche limite, Matrix funzionava, aveva una storia con un suo senso che coinvolgeva, mettendo insieme diverse idee che creavano un mondo e un’atmosfera buoni, senza contare le varie filosofie che davano vita all’anima del film e gli effetti speciali caratterizzati dall’utilizzo del bullet time. Non per niente fu un grande successo, sia di critica sia d’incassi.
Già col secondo film, Matrix Reloaded, le cose non furono le stesse, seppure gli incassi furono superiori a Matrix: la novità e la sorpresa non c’erano già più e si era cercato di mettere qualcosa di nuovo. In parte ha funzionato (l’immissione di un personaggio come il Merovingio), in parte no (l’Architetto lascia un po’ a desiderare); in certe parti sembra essere troppo ricercato ed elaborato, allungando un po’ troppo la storia. Gli effetti speciali sono sempre ottimi, ma la storia non è al livello del predecessore; certo, ci sono delle parti interessanti (il dialogo tra Neo e la Veggente prima dello scontro iconico tra il protagonista e la schiera senza fine della sua nemesi Smith (accompagnato dall’adrenalinico brano Burly Brawl di Juno Reactor & Don Davis) è molto bello), ma non sufficiente da creare la stessa atmosfera.
Le cose non migliorarono con Matrix Revolutions: anche qui la simbologia (il finale “cristiano” legato al sacrificio di Neo) e i vari pensieri si sprecano, stessa cosa vale per scontri ed effetti speciali, ma il film non convince e ha perso la verve iniziale. Il film peggiore della serie. Questo almeno se ci si fosse fermati alla trilogia (c’è da considerare anche Animatrix, un film collettivo d’animazione a episodi, che tutto sommato non è male e fa conoscere un po’ di più il mondo di Matrix, ma è legato marginalmente alla trama principale): con l’arrivo di Martix Resurrections il titolo passa di mano.
Come già detto dal titolo, Neo e Trinity risorgono, ma vivono separatemente e non si conoscono, anche se nel profondo sentono che qualcosa manca. Neo, nei panni di Thomas Anderson, è uno sviluppatore di videogiochi di successo, creatore della serie Matrix che si basa su frammentari ricordi della sua incarnazione precedente; va da uno psichiatra perché ha dei casi in cui non riesce a distinguere la realtà. Dopo essersi “risvegliato” e aver scoperto che era tenuto in una capsula con al fianco Trinity, Neo si mette in moto per combattere il nuovo nemico, l’Analista, e far tornare Trinity a lui.
La trama è stata riassunta molto brevemente, ma a grandi linee è così; quel che è certo, è che Matrix Resurrections non funziona, nemmeno come effetti speciali: si è di fronte a qualcosa di cui si poteva fare a meno.
By M.T., on Settembre 22nd, 2024   Con The Batman ero partito prevenuto e tutto era dovuto alla scelta di Robert Pattison come interprete di Bruce Wayne: memore che aveva recitato nella serie di Twilight, la cosa non mi aveva invogliato né ad andare al cinema né a prendere dvd o roba simile. Ho visto The Batman per curiosità quando è passato in televisione e devo dire che non è stato male come temevo, anzi, direi che il giudizio è abbastanza positivo. Certo, Pattison non è molto espressivo (verrebbe da dire che è monoespressivo), ma è abbastanza adeguato nel ruolo di Batman (anche se ho preferito Crhistian Bale e Michael Keaton): la sua interpretazione di un Bruce all’inizio del cammino di Batman è discreta ed è abbastanza convincente. Molto più convincente però è Zoë Kravitz nel ruolo di Selina Kyle/Catwoman: davvero buona la sua interpretazione (come già in altre pellicole, vedasi quelle della serie Divergent, il secondo film di Animali Fantastici, X-men – L’inizio, Mad Max – Fury Road). Con The Batman ero partito prevenuto e tutto era dovuto alla scelta di Robert Pattison come interprete di Bruce Wayne: memore che aveva recitato nella serie di Twilight, la cosa non mi aveva invogliato né ad andare al cinema né a prendere dvd o roba simile. Ho visto The Batman per curiosità quando è passato in televisione e devo dire che non è stato male come temevo, anzi, direi che il giudizio è abbastanza positivo. Certo, Pattison non è molto espressivo (verrebbe da dire che è monoespressivo), ma è abbastanza adeguato nel ruolo di Batman (anche se ho preferito Crhistian Bale e Michael Keaton): la sua interpretazione di un Bruce all’inizio del cammino di Batman è discreta ed è abbastanza convincente. Molto più convincente però è Zoë Kravitz nel ruolo di Selina Kyle/Catwoman: davvero buona la sua interpretazione (come già in altre pellicole, vedasi quelle della serie Divergent, il secondo film di Animali Fantastici, X-men – L’inizio, Mad Max – Fury Road).
Cosa dire della trama? In un qualche modo ricalca la struttura di Il cavaliere oscuro (a mio avviso il miglior film su Batman finora realizzato) seppur non riesca a raggiungere lo stesso livello, benché tutto sommato si sia su un buon livello. Perché non siamo sullo stesso piano? Uno, perché l’Enigmista non è al livello di Joker come nemico e Paul Dano non può raggiungere la magnifica interpretazione di Heath Ledger. Due, perché gli attori in ruoli secondari danno un’interpretazione migliore in Il cavaliere oscuro. Tre, la storia di The Batman, benché cupa, non raggiunge il dramma di Il cavaliere oscuro: in The Batman non ci sono le stesse perdite che Bruce deve affrontare, anzi, si può dire che non ce ne sono affatto. Certo, Alfred viene ferito; sì, scopre che il padre non era così retto come credeva. Ma il Bruce di Pattison non subisce gli stessi traumi del Bruce di Bale. In Il cavaliere oscuro Bruce si trova a dover fare scelte più combattute e dolorose: se vuole avere una relazione con l’amata Rachel deve scegliere se continuare a essere Batman, trovandosi però costretto a non poterlo fare per non darla vinta al crimine e a Joker; quando deve scegliere tra la vita di Rachel e quella di Dent lui sceglie la prima ma il Joker lo beffa e lui si ritrova a salvare il secondo, con lei che muore nell’esplosione; dopo aver puntato tutto su Dent come paladino di Gotham, si ritrova a dover fare i conti che Dent è diventato uno dei cattivi e ad affrontarlo, vedendo il lavoro che lui e il commissario Gordon hanno fatto andare quasi in frantumi, tutto ciò evitato solo perché come Batman si prende la colpa di tutti i crimini commessi dall’ex procuratore, divenendo così il nemico pubblico numero uno.
In The Batman le cose non sono così drastiche. Gotham è certamente più cupa e corrotta, tutti hanno una parte oscura (tranne forse il commissario Gordon), ma a parte l’assassinio di alcune figure che dovrebbero essere dalla parte della giustizia e invece sono marce e coinvolte in qualcosa di losco, non ci sono perdite eclatanti: alla fine è tutta una questione di mafia e corruzione. L’Enigmista, anche se fuori di testa, ha una ragione nel suo modo di agire che non è poi così sbagliata di base: sta cercando di far venire alla luce un sistema traviato. Certo, il modo in cui lo attua è sbagliato, dato che porterebbe alla fine a una carneficina, ma di base le sue sono le azioni di una vittima di un sistema che è per i potenti, con i deboli che sono sfruttati e gettati sempre più nel fango. Senza contare che il suo modo di agire è ispirato da un Batman mosso da vendetta per la morte dei genitori (non per niente lui dichiara “io sono vendetta”) ed è proprio questo che alla fine fa capire a Bruce che non è il modello, l’esempio che voleva dare alla città e che se vuole che ci sia davvero un cambiamento lui è il primo che deve cambiare.
Interessante il finale che non vede lo scontro fisico tra Batman e l’Enigmista (dove non ci sarebbe storia, dato che, come dice il villain, lui non è un tipo fisico), ma che vede affrontare una minaccia che è molteplice: bello, intelligente nel mostrare i danni che può fare la rete se usata in un certo modo, ma la risoluzione che non avviene con lo scontro finale tra protagonisa e antagonista si è già vista in Il cavaliere oscuro (magnifica la frase che il Joker rivolge a Batman mentre combattono prima di arrivare all’epilogo: “Non avai pensato che rischiassi di perdere la battaglia per l’anima di Gotham in una scazzottata con te?” facendo intendere che le cose non si sarebbero risolte con il loro scontro).
In definitiva The Batman è un buon film, non il migliore ma abbastanza valido da non far pentire di averlo visto (vedasi Batman Forever ma soprattutto Batman & Robin).
By M.T., on Settembre 15th, 2024   I film di Mamoru Oshii non sono mai molto allegri (eufemismo), ma molto probabilmente Jin Roh – Uomini e lupi è quello che lo è meno di tutti. Appartenente alla Kerberos Saga, in una realtà alternativa, un Giappone ambientato negli anni Sessanta è guidato da un governo autoritario; ispirato alle proteste e alle manifestazioni avvenute realmente nel paese nipponico in quel periodo, nel mondo mostrato da Oshii la nazione dopo dieci anni dalla sconfitta nella guerra si sta risollevando economicamente. Tuttavia la crescita forzata ha causato masse di disoccupati e vaste aree metropolitane si degradarono divenendo terreno fertile per una violenta criminalità; da essa sorsero gruppi armati antigovernativi. Le forze di polizia locali non furono in grado di contrastarli e non volendo far intervenire le forze di autodifesa, il governo istituì una terza forza armata, la DIME, Divisione di Sicurezza Metropolitana, dotata di autonomia decisionale e armamento pesante. I movimenti antigoverantivi furono banditi, ma dopo violenta repressione, i reduci si riunirono in un movimento chiamato la Setta; gli scontri tra la Setta e il corpo speciale della Dime si fecero sempre più violenti, rendendo le strade della capitale dei veri e propri campi di battaglia, il che fece aumentare le proteste dell’opinione pubblica. Benché avessero lottato a lungo per difendere il paese, i membri del corpo speciale della DIME, conosciuti come Kerberos, stavano per essere messi da parte. Protettori inflessibili e spietati dell’ordine, il cui nome ricorda quello di Cerbero, cane a tre teste della mitologia greca custode severo dell’entrata nell’Ade ma citato anche nella Divina Commedia (il nome però non è l’unico riferimento infernale: le loro maschere dotate di visori hanno una caratteristica colorazione rossa che si rifà agli occhi di brace di Caronte, altra figura presente sia nella mitologia greca sia nella Divina Commedia), i Kerberos non sono disposti a essere messi da parte o a essere sacrificati per giochi di potere. Ed è qui che inizia la storia di Jin Roh – Uomini e lupi. I film di Mamoru Oshii non sono mai molto allegri (eufemismo), ma molto probabilmente Jin Roh – Uomini e lupi è quello che lo è meno di tutti. Appartenente alla Kerberos Saga, in una realtà alternativa, un Giappone ambientato negli anni Sessanta è guidato da un governo autoritario; ispirato alle proteste e alle manifestazioni avvenute realmente nel paese nipponico in quel periodo, nel mondo mostrato da Oshii la nazione dopo dieci anni dalla sconfitta nella guerra si sta risollevando economicamente. Tuttavia la crescita forzata ha causato masse di disoccupati e vaste aree metropolitane si degradarono divenendo terreno fertile per una violenta criminalità; da essa sorsero gruppi armati antigovernativi. Le forze di polizia locali non furono in grado di contrastarli e non volendo far intervenire le forze di autodifesa, il governo istituì una terza forza armata, la DIME, Divisione di Sicurezza Metropolitana, dotata di autonomia decisionale e armamento pesante. I movimenti antigoverantivi furono banditi, ma dopo violenta repressione, i reduci si riunirono in un movimento chiamato la Setta; gli scontri tra la Setta e il corpo speciale della Dime si fecero sempre più violenti, rendendo le strade della capitale dei veri e propri campi di battaglia, il che fece aumentare le proteste dell’opinione pubblica. Benché avessero lottato a lungo per difendere il paese, i membri del corpo speciale della DIME, conosciuti come Kerberos, stavano per essere messi da parte. Protettori inflessibili e spietati dell’ordine, il cui nome ricorda quello di Cerbero, cane a tre teste della mitologia greca custode severo dell’entrata nell’Ade ma citato anche nella Divina Commedia (il nome però non è l’unico riferimento infernale: le loro maschere dotate di visori hanno una caratteristica colorazione rossa che si rifà agli occhi di brace di Caronte, altra figura presente sia nella mitologia greca sia nella Divina Commedia), i Kerberos non sono disposti a essere messi da parte o a essere sacrificati per giochi di potere. Ed è qui che inizia la storia di Jin Roh – Uomini e lupi.
La polizia è impegnata a contenere una manifestazione della popolazione che presto sfocia in violenza; la Dime, anche lei presente, resta a guardare perché non ha ordine d’intervenire. Membri della Setta s’infiltrano tra i manifestanti, facendo uso di bombe e causando feriti tra la polizia; una ragazzina, assoldata dalla Setta, funge da corriere e ha il compito di consegnare le bombe (non è l’unica: sono tante a venire usate per questo scopo e vengono chiamate Cappuccetti Rossi). Mentre sta seguendo un gruppo della Setta attraverso la rete fognaria per portare a termine la sua missione, viene raggiunta da un gruppo di Kerberos, che era sulle tracce dei rivoltosi; i compagni vengono tutti eliminati e lei è l’unica sopravvissuta. Terrorizzata, scappa ma viene raggiunta da uno dei Kerberos, Kazuki Fuse, che, vedendo che è poco più di una bambina, si blocca, non riuscendo a spararle (i Kerberos hanno l’ordine di eliminare i terroristi, senza eccezioni). La ragazza, presa dal panico, attiva la boma e si fa esplodere. Fuse, grazie all’equipaggiamento corazzato e all’intervento di un compagno, si salva, riportando solo una lieve ferita, ma per questa sua esitazione viene rimandato al centro d’addestramento, dove trova non poche difficoltà ad agire durante le esercitazioni.
Grazie alle dritte di un ex compagno di corso, viene a sapere dove è ubicata la tomba della ragazza e lì incontra la sorella maggiore della vittima, Kei Amemiya, la quale non prova alcun risentimento verso di lui. I due cominciano a parlare e Kei vuole che lui abbia un libro caro alla sorella, la fiaba di Cappuccetto Rosso; iniziano a frequentarsi e Kei gli rivela che in realtà non è la sorella della ragazza uccisa, ma anche lei è un ex corriere della Setta che sta venendo usata dalla Pubblica Sicurezza. Dopo i disordini avvenuti e lo scoppio della bomba, le proteste dell’opinione pubblica sono aumentate al punto che si vuole usare l’esitazione di Fuse per far sparire i Kerberos: le varie forze, escluse quelle dei Kerberos, stanno cercando d’incastrare Fuse con Kei. Il loro piano è di dare una bomba a Kei e farla incontrare in un musero con Fuse così da far sembrare i due in combutta: avendo un membro dei Kerberos coinvolto con la Setta, lo scandalo sarebbe così grande che inevitabilmente il gruppo speciale verrebbe chiuso. Tuttavia, non hanno fatto i conti con Jin Roh, gli uomini lupi, un gruppo del controspionaggio interno ai Kerberos (che i più reputano solo una diceria): informato della trappola, Fuse evita di essere preso e scappa con la ragazza. Però non fugge, nonostante la ragazza lo supplichi di lasciare la città con lei e ricominciare da un’altra parte, dato che ha ancora una cosa da fare. Scesi nelle fognature, sono raggiunti da altri membri dei Kerberos, che portano l’equipaggiamento pesante per Fuse; sono raggiunti anche da coloro che lo volevano incastare, dato che nella borsa della bomba c’era un segnalatore di posizione. Si scopre così che Fuse è un Uomo Lupo, un membro della Jin Roh, che avrà così non solo la possibilità di eliminare i nemici dell’organizzazione, ma potrà anche riscattare la sua esitazione; nessuno rimane in vita, nemmeno l’ex compagno di corso che lo aveva aiutato e faceva parte della cospirazione.
Il complotto è stato sventato e con la ragazza nelle mani della Jin Roh ora le posizioni di potere sono cambiate; tuttavia c’è sempre la possibilità che lei possa essere ripresa. Perché il potere sia sempre nelle mani della Jin Roh, occorre far credere che Kei sia sempre in loro custodia ma non per questo lei deve essere viva: come ultimo segno di essere un Uomo Lupo, Fuse ha l’ordine di uccidere la ragazza. Sebbene straziato da quello che deve fare, mentre Kei recita la parte finale di Cappuccetto Rosso, Fuse le spara; per la ragazza comunque non c’era nessuna possibilità di salvezza: essendo una terrorista, sarebbe stata uccisa comunque (questo è il credo dei Kerberos), anche se non l’avesse fatto Fuse (e probabilmente, se non avesse sparato, lo stesso Fuse sarebbe stato ucciso). Il film si chiude sulle parole dell’istruttore di Fuse che termina il racconto di Cappucceto Rosso col lupo che divora la bambina.
Jin Roh – Uomini e lupi è un film privo di speranza (emblematiche della crudeltà della storia sono le parole dell’istruttore dei Kerberos dette a Kei prima che Fuse entri in azione: “solo nelle favole che raccontano gli uomini i cacciatori uccidono i lupi” e “i membri della Jin Roh sono lupi travestiti da uomini”), dove spesso si fa l’associazione della spietatezza umana a quella del lupo (benché, in realtà, i lupi non sono animali così feroci e spietati, ma sono bestie capaci di gesti affettuosi e premurosi verso i propri simili) e non manca certo la critica dei gruppi che cercano sempre di sopprimire l’individualità perché l’individuo non possa sfuggire al loro controllo (un lupo che va a vivere tra gli uomini e assume le loro sembianze non potrà mai essere uno di loro). Il quadro che fa Oshii non è roseo: la ricostruzione dopo la sconfitta della Seconda Guerra Mondiale (in questo caso dovuto alla Germania nazista) non è andata come si sperava, ha portato un’urbanizzazione violenta e straniante, piena di contestazioni e conflitti, che può essere tenuta sotto controllo solo con la forza. L’influenza tedesca non solo è ben visibile dall’armamento indossato dai Kerberos, ma anche dalla mentalità che si è radicata nel paese. Jin Roh è un’opera ucronica e distopica, che mescola thriller, politica e dramma e che fa un’allegoria della società attraverso la favola di Cappuccetto Rosso dei fratelli Grinn, racconto che è modificato e che è reso più cupo, violento e crudele. In quest’opra di Oshii, l’uomo, la società e le sue strutture non ne escono bene: tutto è pervaso da pessimismo e rassegnazione. Si va avanti perché è inevitabile farlo, ma non si hanno prospettive buone, perché non c’è possibilità di bene, solo cercare di sopravvivere, dove il più forte prevale e non c’è spazio per i sentimenti. Soprattutto c’è un forte senso di solitudine, dove anche se si è nella massa e si cerca di adattarsi a essa, si è sempre soli, incapaci veramente d’integrarsi in una società che è tale solo di nome.
Jin Roh – Uomini e lupi è un’opera complessa, intelligente nella sua crudeltà e spietatezza, che sicuramente merita di essere vista ma per la quale occorre essere preparati, perché colpisce senza esclusioni di colpi e non risparmia nessuno.
By M.T., on Settembre 8th, 2024   Dune di David Lynch l’avevo visto da piccolo e lo ricordavo abbastanza positivamente; certo, c’erano dei momenti di stanca, ma nel complesso il giudizio era buono. Ho voluto rivederlo di recente e tale giudizio non è più buono, non tanto perché ho fatto il confronto con il Dune di Villeneuve (con più di trent’anni di differenza è normale che gli effetti speciali siano migliori), ma perché conosco il romanzo e Lynch si è preso delle licenze che non ho propriamente apprezzato: la prima che mi viene in mente è l’immettere il Modulo Estraniante, l’arma segreta degli Atreides su cui contano per combattere la trappola degli Harkonnen in cui sanno di star per cadere. Non solo tale arma non esiste nel romanzo, ma travisa il motivo per cui il Duca Leto va su Dune: ricercare la forza dei Fremen. Dune di David Lynch l’avevo visto da piccolo e lo ricordavo abbastanza positivamente; certo, c’erano dei momenti di stanca, ma nel complesso il giudizio era buono. Ho voluto rivederlo di recente e tale giudizio non è più buono, non tanto perché ho fatto il confronto con il Dune di Villeneuve (con più di trent’anni di differenza è normale che gli effetti speciali siano migliori), ma perché conosco il romanzo e Lynch si è preso delle licenze che non ho propriamente apprezzato: la prima che mi viene in mente è l’immettere il Modulo Estraniante, l’arma segreta degli Atreides su cui contano per combattere la trappola degli Harkonnen in cui sanno di star per cadere. Non solo tale arma non esiste nel romanzo, ma travisa il motivo per cui il Duca Leto va su Dune: ricercare la forza dei Fremen.
Altra cosa che non ho apprezzato è come sono stati usati personaggi come Duncan (figura molto importante per Paul) che fa una breve apparizione e muore come un qualsiasi altro soldato mentre la sua fine è molto più epica e drammatica (in questo è stato bravo Jason Momoa nel film di Villeneuve); come il dottor Kynes (Max von Sydow, per il poco tempo che appare, è davvero sprecato in questo film), come Chani (altra figura importante per Paul, qui mostrata come semplice ragazza perdutamente innamorata del protagonista) o come Thufir Hawat (figura complessa che Lynch purtroppo usa male e fa uscire malamente di scena).
Rappresentare il romanzo di Herbert non è facile, vista la grandezza e la complessità dell’opera, e bene ha fatto Villeneuve a dividerlo in due parti per cercare di mostrare il più possibile; Lynch in poco più di due ore e quindici minuti cerca di mettere tutto e per farlo deve comprimere, tagliare e inevitabilmente tralasciare qualcosa, su tutto il messaggio ecologista del libro, il mostrare il rapporto tra l’uomo e l’ambiente creatosi tra il pianeta Dune e i Fremen, che Paul col tempo arriva a conoscere. Degli studi e del lavoro del dottor Kynes (cercare di trasformare il pianeta desertico di Dune in un mondo verde) non c’è traccia: tutto si concentra su Paul, alla fine mostrato praticamente come un dio, capace di far piovere su Dune (cosa non vera, perché non sono i suoi poteri a far arrivare la pioggia, ma tutto il lavoro che è stato fatto portando avanti gli studi di Kynes).
Purtroppo, conoscendo la storia, il Dune di Lynch è qualcosa di frettoloso e pure raffazzonato (in una scena finale, prima dello scontro tra Paul e Feyd-Rautha (interpretato da Sting), si vede Chani con due bambini gemelli, i figli che ha avuto con Paul: la cosa è sbagliata perché uno, il bambino che ha avuto con Paul nel romanzo Dune è stato ucciso durante un attacco nemico, e due perché i gemelli (un maschio e una femmina) li avrà in Messia di Dune, morendo subito dopo il parto; forse non è tutta colpa sua, forse sono stati fatti troppi tagli, andando a inficiare la qualità della pellicola, ma il giudizio che viene dato dopo averlo rivisto è negativo, da cui si salvano i vermi delle sabbie di Carlo Rambaldi e la fotografia di Freddie Francis (la rappresentazione degli scudi è meglio però lasciarla perdere).
By M.T., on Settembre 1st, 2024   Cosa dire di Watchmen? Non molto, se non che è una delle migliori graphic novel finora realizzate. Qualcuno asserisce che è un capolavoro, qualcun altro sentendo una simile affermazione storce il naso perché i capolavori sono altri: a ognuno il suo. Per me rimane un’opera molto valida e meritevole d’essere sia letta sia vista; con le dovute piccole differenze, sia il fumetto realizzato da Alan Moore sia la trasposizione cinematografica sono da seguire. E fa sorridere che nonostante il film sia uno dei pochi a mantenere trama e spirito dell’opera originaria, Alan Moore fosse contrario alla sua realizzazione (in realtà, l’autore britannico è contrario a qualsiasi trasposizione cinematografica delle sue opere). Cosa dire di Watchmen? Non molto, se non che è una delle migliori graphic novel finora realizzate. Qualcuno asserisce che è un capolavoro, qualcun altro sentendo una simile affermazione storce il naso perché i capolavori sono altri: a ognuno il suo. Per me rimane un’opera molto valida e meritevole d’essere sia letta sia vista; con le dovute piccole differenze, sia il fumetto realizzato da Alan Moore sia la trasposizione cinematografica sono da seguire. E fa sorridere che nonostante il film sia uno dei pochi a mantenere trama e spirito dell’opera originaria, Alan Moore fosse contrario alla sua realizzazione (in realtà, l’autore britannico è contrario a qualsiasi trasposizione cinematografica delle sue opere).
Per questione di tempi (la versione cinematografica dura sulle due ore e quaranta minuti) alcune parti sono state tagliate, ma se si è interessati è possibile vederle nel dvd I racconti del Vascello Nero, che contiene per l’appunto I Racconti del Vascello Nero e Sotto la maschera, l’auotbiagrafia di Hollis Mason, il primo Gufo Notturno; la loro assenza nella pellicola del 2009 di Zack Snyder non pregiudica la comprensione della storia, ma la loro visione permette di approfondire e comprendenre maggiormente il mondo di Watchmen; se l’autobiografia di Mason permette di saperne di più su come sono nati i Watchmen e capire come si è arrivati al punto in cui la storia viene narrata, per I Racconti del Vascello Nero le cose si fanno un po’ più sottili: esso è un metafumetto, ovvero un fumetto dentro al fumetto, e viene letto da un ragazzo presso un’edicola. Si tratta di una storia di pirati che narra la discesa verso la pazzia di un uomo, unico sopravvissuto di una nave, che cerca di tornare a casa per avvisare i concittadini dell’arrivo della nave pirata Vascello Nero. Se a qualcuno la narrazione di tale storia può essere avulsa da quella di Watchmen, beh, le cose non stanno proprio così: I racconti del Vascello Nero presenta forti analogie con uno dei membri del gruppo dei Watchmen e aiuta a comprendere meglio la sua psiche e diventa metafora del cammino che ha deciso d’intraprendere. Non rivelerò chi è il personaggio in questione per non dire troppo, ma posso affermare che ben si associa con l’oscurità del metafumetto.
C’è anche un’altra differenza tra fumetto e film: l’evento che porta alla conclusione della storia. O meglio, ciò che causa la catastrofe che farà riunire i Watchmen rimasti, l’evento che il Comico aveva scoperto e per il quale aveva pianto, venendo poi ucciso a causa di tale scoperta perché non rivelasse ogni cosa.
Oltre a essere una storia interessante, che fa riflettere sul fine che giustifica i mezzi e su come gli eventi e l’ambiente possono condizionare e cambiare le persone, il punto forte di Watchmen sono i personaggi, la loro complessità, la loro profondità. Watchmen non è la solita storia di supereroi, anzi, a pensarci bene di supereroi (ovvero individui con superpoteri) c’è solo il Dottor Manatthan,che praticamente può fare di tutto (solo che questo suo smisurato potere lo fa allontanare sempre più dall’umanità, sia sua, sia come appartenenza alla specie): i restanti membri del gruppo sono persone normali, dei vigilantes che a un certo punto hanno preso a combattere il crimine e si sono uniti in un gruppo, il tutto con l’approvazione del governo, almeno fino a quando non è stato deciso di mettere a riposo i Watchmen (uno, Rorschach, continua a fare il vigilantes e per questo viene ricercato dalla polizia; il Cominco e il Dottor Manhattan diventano agenti governativi).
La bellezza di Watchmen è il calare questi supereroi in un contesto reale, mostrando le loro debolezze (l’ultimo Gufo Notturno), i loro lati oscuri (il Comico), i loro tormenti (Rorschach); queste persone non sono diventate eroi per un bene superiore, per la giustizia, ma ognuno ha le sue ragioni: per il Comico è avere un modo per usare la violenza (spesso viene accusato di essere un fascista), per Rorschach è combattere il crimine senza compromessi (soprattutto dopo che una bambina è stata rapita e massacrata, data in pasto a dei cani furiosi), per la seconda Spettro di Seta è seguire le orme della madre (uno dei dialoghi più belli lo si ha quando scopre chi è il proprio padre), per Ozymandias quelle di Alessandro Magno.
Ma non ci si ferma a questo: l’opera è piena di simbolismi. Riferimenti agli orologi, al nodo gordiano, agli egizi, al famoso smiley tanto caro al Comico, all’ombra della minaccia nucleare (presente nel mondo fin da quando si è pensato di usare l’energia atomica a scopi bellici).
In Watchmen praticamente funziona tutto: incipit, sviluppo, finale. Un finale lasciato in un qualche modo aperto, a suo modo amaro ma anche bellissimo. Non per niente Watchmen ha cambiato, assieme Il ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller, il modo d’intendere e di fare il fumetto supereroistico; pertanto, merita di essere tra le migliori opere (non solo fumettistiche) mai realizzate.
By M.T., on Agosto 25th, 2024   Come Il Cavaliere della Rosa Nera, anche I Draghi del Sole Morente di Margaret Weis e Tracy Hickman l’avevo acquistato all’uscita (parliamo di più di venti anni fa, era il 2001), subito seguito da I Draghi della Stella Perduta, dato che facevano parte della trilogia di Dragonlance La Guerra delle Anime; dopo poco più di cento pagine però l’avevo abbandonato (motivo per cui non acquistai il terzo volume, recuperato qualche anno dopo in una bancarella dell’usato per un paio di euro), perché la storia non mi prendeva (questo probabilmente perché dopo aver letto abbastanza di quel mondo stavo ricercando altro dalle letture e in quel periodo, e per diversi anni successivi, più che leggere narrativa andavo su altri generi come a esempio la saggistica). Vuoi perché mi sono ritrovato in mano i libri sistemando scaffali e scatoloni, vuoi perché è un periodo in cui ho deciso di portare a compimento cose che non ho concluso, ho deciso di riprendere in mano I Draghi del Sole Morente e finirlo (in verità l’ho ricominciato, perché della storia ricordavo davvero poco). Come Il Cavaliere della Rosa Nera, anche I Draghi del Sole Morente di Margaret Weis e Tracy Hickman l’avevo acquistato all’uscita (parliamo di più di venti anni fa, era il 2001), subito seguito da I Draghi della Stella Perduta, dato che facevano parte della trilogia di Dragonlance La Guerra delle Anime; dopo poco più di cento pagine però l’avevo abbandonato (motivo per cui non acquistai il terzo volume, recuperato qualche anno dopo in una bancarella dell’usato per un paio di euro), perché la storia non mi prendeva (questo probabilmente perché dopo aver letto abbastanza di quel mondo stavo ricercando altro dalle letture e in quel periodo, e per diversi anni successivi, più che leggere narrativa andavo su altri generi come a esempio la saggistica). Vuoi perché mi sono ritrovato in mano i libri sistemando scaffali e scatoloni, vuoi perché è un periodo in cui ho deciso di portare a compimento cose che non ho concluso, ho deciso di riprendere in mano I Draghi del Sole Morente e finirlo (in verità l’ho ricominciato, perché della storia ricordavo davvero poco).
Ma prima di addentrarsi nella trama del romanzo, occorre un breve riassunto di come stanno le cose su Krinn. In Le Cronache di Dragonlance, i draghi erano ritornati, così come i veri dei; la malvagia Regina delle Tenebre Takhisis, la dea che stava dietro tutte le vicende, viene sconfitta. La trilogia si conclude con l’ascesa di Raistlin a mago più potente su Krinn, dando poi il via a un’altra trilogia, Le Leggende di Dragonlance, che vede il suo gemello Caramon contrapporsi al suo piano di prendere il prendere il posto nel pantheon degli dei della Regina delle Tenebre; in questa storia avrà un ruolo importante un artefatto magico, il congegno di viaggiare nel tempo. Alla fine, Raistlin rinuncerà al suo obiettivo, rimanendo nell’Abisso per fermare Takhisis.
Si arriva così alla Guerra del Caos, in special modo a I Draghi dell’Estate di Fuoco, che vede i figli degli Eroi delle Lance e gli Eroi rimasti combattere contro un nemico comune, Caos; la vittoria arriderà a loro, ma non senza sacrifici: Tasslehoff muore nello scontro finale contro il gigantesco nemico (Tanis è morto poco prima) e Raistlin lascia Krinn assieme agli dei, che abbandonano il mondo per permettere ai propri figli di continuare a vivere, anche se non avranno più la magia.
Inizia così la Quinta Era, che vede l’ascesa dei Dragoni e la riscoperta della magia; questa serie non è scritta dal duo Weis/Hickman, ma da Jean Rabe ed è la peggiore serie realizzata su Dragonlance: da evitare. Tuttavia, parlare di essa serve per arrivare al punto in cui inizia I Draghi del Sole Morente: tutto inizia quando un gruppo di Cavalieri di Neraka (un tempo Cavalieri di Takhisis) incontrano una giovane donna di nome Mina (di cui un tempo si è presa cura Golmoon) che predica l’Unico Dio. Dopo aver ridato il braccio mancante a Galdar, un minotaro, Mina conduce i cavalieri alla volta di Sanction, dove stanno tenendo un assedio contro i Cavalieri di Solamnia.
Nel frattempo, Alhana Starbreeze sta cercando di rientrare nel regno di Silvanesti dopo che si è isolato sotto uno scudo magico e suo figlio Silvan vuole avere la possibilità di dar prova di sé; possibilità che avrà quando dovrà andare a chiedere aiuto per un attacco di orchi. La sua missione fallirà perché cadendo e perdendo i sensi si ritroverà all’interno dello scudo, dove verrà riconosciuto come re degli elfi, essendo lui nipote ed erede di Lorac, colui che fece cadere Silvanesti in un incubo quando il regno cadde sotto le grinfie del drago Cyan Bloobane dopo aver tentato di usare un Globo dei Draghi.
A Qualinesti, il figlio di Laurana e di Tanis, il Presidente dei Soli Gilthas, recita la parte del re malaticcio e malinconico, perso dietro rime e poesie, ma in realtà collabora con i ribelli per opporsi ai Cavalieri di Neraka e alla dragonessa Beryl.
A Solace, il Cavaliere di Solamnia Gerard mentre è di guardia alla Tomba degli Ultimi Eroi ha una sorpresa inaspettata: la tomba si apre e da essa ne esce un kender che si fa chiamare Tasslehoff Burrfoot, giunto per partecipare al funerale di Caramon Majere. Naturalmente Gerard non crede alle sue parole, dato che già altri trentasette kender si fanno chiamare così, ma Tas riesce a sfuggire alla sua custodia e a raggiungere il vecchio amico (ancora vivo), che lo riconosce. Tas gli racconta che è arrivato lì con il congegno per viaggiare del tempo, datogli da Fizban perché potesse essere al suo funerale. Questa è la terza volta che viaggia nel tempo, dato che per un motivo o per l’altro è arrivato tardi alla cerimonia le altre due volte; la storia che Tas gli racconta è diversa dalla realtà in cui è giunto e proprio mentre finisce il racconto, Caramon ha un attacco di cuore e muore, ma non prima di aver detto che c’è qualcosa che non va perché suo fratello Raistlin non c’era al momento della sua dipartita e affida una missione a Gerard, venuto a riprendere il kender: portare Tas e il congegno magico da Dalamar, il mago elfo un tempo allievo di Raistlin.
Nella Cittadella della Luce, l’ormai anziana Goldmoon si ritrova improvvisamente ringiovanita dopo la spaventosa tempesta che si è scatenata sul mondo e che ha visto fare la strepitosa comparsa di Mina.
Questi sono i punti di partenza della trilogia La Guerra delle Anime. Dopo le prime pagine, Alhana finisce dietro le quinte per lasciare posto al figlio Silvan, con cui è difficile provare simaptia ed empatia, dato che fa i capricci come un bambino e ha l’intelligenza e il carisma di un troll: sicuramente uno dei personaggi peggio riusciti della serie, e non è che gli altri brillino poi tanto.
Il problema di questa serie sono proprio i personaggi, che non si avvicinano minimamente al livello dei protagonisti di Le Cronache di Dragonlance: Gerard non è Sturm, Palin non ho lo spessore di Raistlin, Tas privato di Flint fa fatica a ingranare, Laurana è l’ombra di quella che era un tempo. Un po’ meglio va col maresciallo dei Cavaliere di Neraka Medan e con Gilthas, che hanno po’ più di carattere e spessore dei precedenti persoanggi.
Per quanto riguarda la storia, interessante come la storia sia stata modificata col viaggiare nel tempo di Tas, anche se non ci si spiega come le vicende siano cambiate solo col terzo viaggio e non con anche gli altri due. Valida anche l’idea di come la magia sta lentamente svanendo (sono gli spiriti dei morti che si stanno nutrendo di essa). Per quanto riguarda l’Unico Dio, ancora non si sa nulla, ma già dei sospetti si hanno, dato che o c’è cieca obbedienza in chi ha ricevuto guarigioni verso questa divinità, oppure ci saranno ritorsioni (e questo non può venire certo da un’entità superiore benevola); il sospetto è che si sia dinanzi a un ripetersi di quanto già visto in Le Cronache di Dragonlance e se così fosse, non sarebbe un gran tocco d’originalità.
In definitiva, I Draghi del Sole Morente non è da buttare, ma è ben lontano dalle opere meglio riuscite di Weis e Hickman; se non è piaciuta la prima trilogia (Le Cronache), allora è meglio lasciarlo perdere.
|
Le mie 10 righe dai llibri
|
 Defiant conferma le impressioni che avevo avuto con Cytonic: la saga sci-fi di Brandon Sanderson è andata in calare. Con Skyward e Starsight, i primi due volumi della serie, la storia si era mantenuta su un buon livello, risultando coinvolgente e convincente, mentre con il terzo, il già citato Cytonic, si era cominciato ad avvertire una certa mancanza di mordente. Forse era stato l’immettere una sorta di giocare ai pirati di Spensa, forse era stata la specie di ricerca alla Indiana Jones (qualcuno potrà dissentire su quanto scrivo, ma tale è l’impressione che ho avuto leggendo Cytonic), ma ho trovato il tutto un poco fuori posto con l’ambientazione fantascientifica letta fino a quel punto. Sia chiaro: la fantascienza realizzata da Sanderson non è niente di complesso (nulla a che vedere con il mondo e la storia di Dune di Herbert), ma è godibile, almeno fino al terzo romanzo. Continua a esserlo anche con esso e dopo di esso, ma non è più la stessa cosa dell’inizio, non sorprende e non prende più allo stesso modo; è possibile che ciò dipenda dal fatto che la serie è indirizzata a un pubblico young adult e visto che ormai non ho più quell’età da un pezzo (gli anni si sono accumulati e così pure le letture fatte), la percezione e l’impressione sull’opera possono essere diverse (potrei dissentire su tale ipotesi, dato che i primi due romanzi mi erano piaciuti e mi avevano convinto e non è che ero adolescente quando li ho letti).
Defiant conferma le impressioni che avevo avuto con Cytonic: la saga sci-fi di Brandon Sanderson è andata in calare. Con Skyward e Starsight, i primi due volumi della serie, la storia si era mantenuta su un buon livello, risultando coinvolgente e convincente, mentre con il terzo, il già citato Cytonic, si era cominciato ad avvertire una certa mancanza di mordente. Forse era stato l’immettere una sorta di giocare ai pirati di Spensa, forse era stata la specie di ricerca alla Indiana Jones (qualcuno potrà dissentire su quanto scrivo, ma tale è l’impressione che ho avuto leggendo Cytonic), ma ho trovato il tutto un poco fuori posto con l’ambientazione fantascientifica letta fino a quel punto. Sia chiaro: la fantascienza realizzata da Sanderson non è niente di complesso (nulla a che vedere con il mondo e la storia di Dune di Herbert), ma è godibile, almeno fino al terzo romanzo. Continua a esserlo anche con esso e dopo di esso, ma non è più la stessa cosa dell’inizio, non sorprende e non prende più allo stesso modo; è possibile che ciò dipenda dal fatto che la serie è indirizzata a un pubblico young adult e visto che ormai non ho più quell’età da un pezzo (gli anni si sono accumulati e così pure le letture fatte), la percezione e l’impressione sull’opera possono essere diverse (potrei dissentire su tale ipotesi, dato che i primi due romanzi mi erano piaciuti e mi avevano convinto e non è che ero adolescente quando li ho letti).




.jpg)
.jpg)

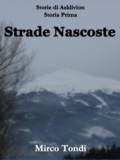







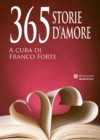













Commenti recenti