Sul sito di Lara Manni, in questo articolo , si parla di come Tolkien nel Signore degli Anelli non dia molto spazio alla speranza. Temi come la perdita e la morte sono profondi e radicati in quest’opera, così come lo sono l’orrore per la guerra, lo sfruttamento e la distruzione della natura, la brutalità e l’inumanità dell’industrializzazione: un’opera fantastica che mostra lati della realtà. Si prova tristezza e disperazione di fronte alle immagini nate da queste parole, così come s’avvertono anche nel finale quando si comprende che ogni ciclo dell’esistenza ha termine, che il passato non può più tornare e che quanto è stato è perduto.
Ma è davvero andato perduto per sempre? Certo, ogni attimo, ogni periodo è unico, non ce n’è uno uguale all’altro: è tutto un divenire e si può provare malinconia per qualcosa di bello che ha dato tanto.
Allora perché si prova disperazione?
Forse perché si rimane attaccati a esperienze che hanno segnato. Affetto, certo, ma anche attaccamento, un appoggiarsi agli altri. Se ci si riflette un attimo, qualsiasi individuo trova negli altri un appoggio, un sostegno. Un fattore normale, dato che l’uomo viene considerato un animale sociale, che cresce in mezzo ai suoi simili e che se costretto all’isolamento s’ammala e muore. Ma cosa succede se quanto è importante, ciò a cui si tiene viene a mancare, se ne viene privati?
Dolore, anche cocente, che solo il tempo attuirà riuscendo a far rivedere il calore perduto. Così è la vita: dolce e amara allo stesso tempo. L’esperienza, il vissuto faranno raggiungere questa comprensione, facendo andare oltre. Ma richiede impegno, fatica e sudore; può stancare, certo. E anche molto, specie quando intorno non si ha un quadro confortante.
Fa riflettere il post di G.L. D’Andrea. Una stanchezza che va oltre quella fisica e mentale: ci si stanca della gente, del suo modo di fare, di vivere. Così scialbo, misero, povero. Così svilente e di scarso valore.
Stanchezza, rassegnazione, senso d’impotenza di fronte a un vivere chiuso in se stesso, limitato dall’egoismo e dal narcisismo, dal prendere (e pretendere) e non dare nulla.
Sì, ci si stanca della gente, anche di quelle persone che si professano amiche, che si ricordano dell’altro solo se hanno bisogno, ma che se devono contraccambiare o essere di sostegno non vogliono trovare il tempo, impegnati a pensare solo a se stessi. Individui egocentrici e accentratori, che basano l’esistenza sul culto dell’ego e della propria persona, gente superficiale e vuota, priva di valore.
Sì, ci si stanca di gente del genere, capace solo di ferire e distruggere, di basarsi sull’apparenza e sul giudizio degli altri.
Questa è la realtà. Una realtà che molto smentirebbero, dicendo che non è vero, profondendosi in dichiarazioni d’amicizia, di buoni sentimenti, di valori elevati.
Sono solo parole.
Parole vuote, che non hanno valore, che servono alla gente a far tacere la coscienza, a sentirsi a posto, a sentirsi delle “brave” persone, cercando di mantenere quelle apparenze, quella bella immagine che vogliono il mondo abbia di sé. Semplici maschere. O come le definiscono alcuni, ipocrisie.
E’ l’atteggiamento, quello che si fa, che conta e rivela ciò che si è veramente. Se una persona si dichiara amica, afferma di sentirsi legata a un altro da un bellissimo legame e poi nel momento del bisogno trova qualsiasi scusa per non esserci, perché impegnata a divertirsi, a dover andare in ferie, ha tempo per tutto fuorché per chi ha bisogno (e che invece c’è sempre stato quando lei si è trovata nella necessità), si può parlare d’amicizia?
No, solo d’approfittarsi, d’usare l’altro, che viene considerato solo un oggetto, uno strumento da usare nel momento del bisogno e poi si mette da parte.
Un individuo di fronte a questa realtà si sente ai margini, sente di non poter far parte di un mondo del genere, di non potersi adattare. Magari può avvertire un moto d’essere come gli altri, di essere parte di qualcosa e non sentire quella diversità che lo fa essere così distante dal mondo. Ma alla volte adattarsi è impossibile, troppo grande il divario tra il proprio essere e il modo di vivere comune.
Una realtà ben mostrata dal film A trenta secondi dalla fine, la cui sceneggiatura originale è stata realizzata dal grande regista Akira Kurosawa, una persona capace di cogliere con grande perizia le sfumature dell’animo umano. La trama è semplice, di quelle ben conosciute. Due carcerati evadono dal penitenziario di massima sicurezza di Stone Heaven in Alaska, raggiungendo una stazione e salendo su un treno da usare come mezzo di fuga per allontanarsi il più possibile dalla prigione e far perdere le proprie tracce. Un incidente al macchinista fa sì che il treno merci viaggi senza controllo (simbolo di come l’uomo nonostante la tecnologia a disposizione non possa controllare ogni cosa). Il direttore del carcere, Ranken, deciso a riacciuffare gli evasi (soprattutto Oscar Mannheimer detto Manny, con il quale ha un conto in sospeso), si getta in un inseguimento che lo condurrà all’epilogo della vicenda.
La forza di questo film è la caratterizzazione di Manny, il personaggio principale, individuo carismatico, fuori dalle righe: l’uomo che non si piega alle regole, colui che è consapevole che potrà essere sempre e soltanto fuori dal sistema, che non potrà mai integrarsi insieme agli altri, il suo essere troppo eccessivo per poter cambiare e adattarsi. Uno spirito libero che non può essere trattenuto nè da sbarre reali (quelle della prigione) nè da sbarre invisibili (quelle del modo di vivere della società).
Sbarre invisibili. Il vivere della società, i rapporti tra le persone, fatte di condizionamenti, possessività, egoismi, l’accontenstarsi di un vivere mediocre sono prigioni. E’ così: i modelli proposti dallo stile di vita della società sono una prigionia, tengono legati e incatenati: una vita passata dietro le sbarre facendo trascorrere gli anni senza vivere veramente, facendo affievolire un giorno dietro l’altro la luce presente nello sguardo, un’esistenza di quieta disperazione.
In un sistema che sopravanza, che coltiva la supremazia di un individuo sull’altro, vincere, perdere…che differenza fa?
“Sono Libero, Ranken! Sono Libero!” E’ una delle frasi di Manny dell’intenso finale.
Sì: libero di essere se stesso. A qualsiasi prezzo, contro qualsiasi logica. Oltre ogni comprensione.





.jpg)
.jpg)

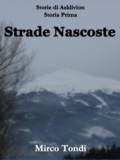







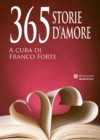





Uno dei miei film preferiti 🙂
Nella vita reale però solo pochissimi uomini sono in grado di pagare l’altissimo prezzo della libertà. E non si può essere liberi per sempre ma si verrà distrutti dalla società.
Però i pochi momenti in cui si è liberi sono bellissimi e valgono un’intera vita. 🙂
Mi associo: è un film stupendo, in pochi ho trovato una simile intensità.
Ed è vero quello che scrivi: davvero pochissime sono le persone che riescono a essere libere. E’ già tanto se ci si riesce a sprazzi.
Eppure sono convinto che sia questa la vera condizione che rispecchia la natura umana.
Sì, ma quanto è dura guadagnarsi la libertà? A volte bisogna lottare anche contro sè stessi, perchè ormai schiavi del consumo e dell’offerta non ci rendiamo nemmeno conto di esserci venduti.
Tanto. E il prezzo da pagare elevato, dato che porta isolamento, incomprensione, essere messo da parte dai propri simili.
Ma è meglio adattarsi, avvertendo sempre un fastidio, un’insoddisfazione di fondo o camminare senza aver bisogno di stampelle?
La risposta non è così semplice e facile come sembra.