Racconto che ho scritto per il contest Mezzogiorno d’Inchiostro 102 di Writer’s Dream con tema L’umiliazione.
«Papà, quando mi compri il nuovo smartphone?»
«Se vai bene a scuola, allora ci penseremo.»
«Ho la sufficienza in tutte le materie.»
«La sufficienza non basta: devi avere almeno sette in tutte le materie. Se alla fine dell’anno scolastico avrai ottenuto questo risultato, allora vedremo di prendere lo smartphone.»
«La fine dell’anno scolastico?! Ma dovrò aspettare dei mesi!»
«Le cose bisogna guadagnarsele.»
«Ma ai miei amici i loro genitori l’hanno già comprato!»
«Loro fanno in un modo, io un altro.»
«Ma…»
«Niente ma: questo è quanto.»
Vidi Matteo fremere stizzito, i pugni chiusi, le labbra serrate. Fece per voltarsi e lasciare la stanza, ma poi ci ripensò. «La tua è una scusa perché non hai soldi per comprarlo.»
“Prima o poi l’argomento sarebbe stato toccato: Matteo non è uno stupido. Certo non occorre un genio per capire che la situazione è cambiata: è fin troppo chiaro.” Posai gli attrezzi con cui stavo riparando il lavandino e mi voltai a guardarlo negli occhi. «È vero, in questo periodo i soldi sono meno e quelli che ci sono servono per l’indispensabile: bollette, spese per la casa, la scuola, l’auto. Non ne rimangono per altro.»
«E tutto perché hai perso il lavoro.» Le parole di Matteo erano un’accusa spietata.
«Sì.» Non era bello da dire a voce alta, ma questa era la realtà.
«Allora trovane un altro!» La rabbia di mio figlio era appena trattenuta.
Capivo il suo stato d’animo: stare in mezzo a ragazzi con possibilità economiche migliori, essere quello che ha meno degli altri, può essere umiliante. E quando si ha a che fare con figli di papà che non si fanno scrupolo di farlo notare in continuazione, può esserlo ancora di più. Per questo ho sempre avuto remore nell’avere figli: non volevo che ripetessero la mia stessa esperienza. Nella mia famiglia d’origine solo mio padre lavorava, ma i miei non mi hanno mai fatto mancare l’indispensabile; anch’io avrei voluto di più, ma capivo che di più non potevano fare. Non lo capivano invece quelli con cui andavo a scuola, abituati ad avere tutto quello che chiedevano: per questo le denigrazioni e le prese in giro erano una costante. L’adolescenza può essere tante cose: l’età dei sogni e delle speranze, ma anche il periodo in cui si è più bastardi e crudeli. E oltre a umiliare, la bastardaggine può ferire in modi che segnano a lungo, lasciandoti diffidente e sfiduciato verso gli altri e il mondo.
Quando ho conosciuto Anna, vedendo che avevamo la stessa visione della vita, ho pensato che i miei timori potevano essere superati, che la storia non si ripetesse. Ci siamo impegnati perché a Matteo non mancasse nulla; ci abbiamo provato con tutta la nostra buona volontà. Ma spesso la vita se ne frega della buona volontà; soprattutto se ne fregano gli altri. In un mondo dove contano la riuscita, il prevalere e il prevaricare, il crescere un figlio perché diventi un individuo equilibrato, che sappia stare in piedi da solo e pensare con la propria testa, è qualcosa di molto difficile. Sarebbe più semplice dargli tutto quello che vuole come fanno in tanti, ma sarebbe uno sbaglio, perché non gli si fa capire il senso della conquista, della responsabilità; non gli si insegna il senso della vita, come affrontarla, come resistere ai suoi colpi, a tenere duro e a rialzarsi quando ti sbatte per terra. Non è facile far comprendere questi valori a chi è giovane, specie se ha a che fare con coetanei che simili valori non hanno avuto.
«Non è così semplice trovarlo.»
Come trovare le parole giuste senza che sembrino delle scuse?
La crisi ha portato la perdita di molti posti di lavoro e le politiche dei governi non hanno certo agevolato a creare nuova occupazione. Quando ero giovane, chi era alle prime armi come me faceva fatica a trovare un’occupazione perché le ditte cercavano lavoratori con anni d’esperienza; ora che sono vicino a cinquant’anni e ho accumulato esperienza, essa è diventata inutile, perché le ditte cercano giovani sotto i ventotto anni, visto che costano meno con le agevolazioni.
Con il senno di poi, avrei dovuto finire l’università; magari con una laurea avrei avuto maggiori sbocchi, soprattutto all’estero. Invece ho preferito lasciare gli studi e andare a lavorare: non sopportavo l’idea di farmi il mazzo e vedermi passare davanti della gente che aveva raccomandazioni o i cui genitori erano amici dei professori. Era una cosa che mi faceva incazzare: valere più di loro, sapere le cose meglio di loro e non avere i loro voti era qualcosa che mi faceva andare fuori di testa. Senza contare che protestare non sarebbe servito a nulla: la moltitudine dava il suo assenso silenzioso perché fare diversamente avrebbe portato solo a derisioni, a passare per invidiosi, nella migliore delle ipotesi; nella peggiore si sarebbe avuto la vita impossibile perché, anche se la verità era sotto gli occhi di tutti, non bisognava dirla. Tanti la pensavano come me, ma nessuno osava fare nulla, preferendo subire, cercando di tirare avanti alla meno peggio. La rassegnazione, il lasciar fare, quando in mano si avevano tutte le carte per cambiare la situazione, erano cose che non digerivo: per me erano uno sminuire il valore di una persona. Potevamo essere un fronte compatto se ci fossimo uniti: saremmo stati una forza non indifferente, che poteva essere ascoltata. Invece, tutti hanno preferito non combattere; hanno perso senza nemmeno giocare. Visto questo modo di fare, ho lasciato l’università disgustato. Ma mi sono sempre portato dietro un senso di sconfitta, di aver mancato l’occasione di poter fare qualcosa se mi fossi battuto.
Così è stato anche quando ho perso il lavoro.
Avevamo le prove che la ditta giocava sporco, faceva mobbing sulle persone di cui si voleva sbarazzare per ridurre i costi: potevamo agire, cambiare la situazione. Ma i miei colleghi erano rassegnati, hanno subito senza alzare la testa: non si sono voluti unire, non hanno voluto fare causa alla dirigenza per non avere grane, per continuare ad avere la vita tranquilla, convinti che tanto si sarebbe trovato un altro posto di lavoro. Così ci hanno sbattuto fuori come cani bastonati, lasciati a noi stessi perché anche il sindacato se n’è fregato visto che subivamo senza fare nulla. Avremmo potuto far valere i nostri diritti e avere ancora un lavoro; invece nessuno di quelli licenziati da allora ne ha più trovato uno.
“E adesso sono qui, un disoccupato ormai non più giovane che cerca di far ragionare un giovane arrabbiato perché non può essere come gli altri.”
«Beh, cerca di darti da fare!» Matteo aprì la porta, mandandola a sbattere contro il muro. «Non mi va di farmi prendere per il culo per colpa tua!» Si fermò nel corridoio. «Hanno ragione gli altri: non è bello essere figlio di un fallito» sibilò prima di scendere le scale.
Come spiegare al proprio figlio che ci sono cose più importanti dei soldi, che la vita è molto di più di quello che può comprare il denaro? Chi non passa attraverso questa esperienza non sa che boccone amaro è non riuscire a comunicare con lui, non trovare le parole perché eviti certi sbagli e comprenda determinate realtà. Non è facile accettare che i discorsi alle volte non servono, che solo vivendole personalmente si posso comprendere certe lezioni, perché l’esperienza non può essere trasmessa, ma solo acquisita vivendola. Anche se lo si desidera, non gli si possono evitare sofferenze e amarezze, non lo si può proteggere dal peggio che c’è nel mondo.
Questa, di tutte le esperienze affrontate, è la più dura da accettare. E solo un padre può capire quanto è umiliante.





.jpg)
.jpg)

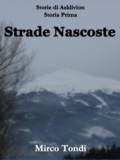







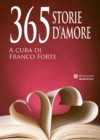





Leave a Reply