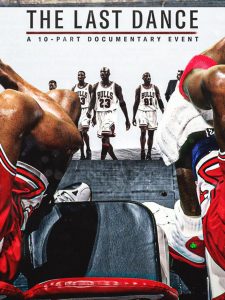 The last dance sono le parole usate da Phil Jackson per definire la sua ultima stagione sulla panchina dei Chicago Bulls e che danno il nome all’omonimo documentario sulla famosa squadra che negli anni 90 ha fatto la storia dell’NBA. La serie vorrebbe mostrare il culmine del successo di questa squadra di basket ma, anche se in parte lo fa, è più che altro concentrata sulla carriera di Michael Jordan. Certo, nelle prime puntate vengono mostrati due giocatori fondamentali al successo come Scottie Pippen e Dennis Rodman, ma più che altro, grazie ai tanti flash back, è la carriera di Jordan a essere al centro dell’attenzione (anche se viene dato un poco di spazio a elementi del team come Steve Kerr, Tony Kukoc, John Paxon e Horace Grant).
The last dance sono le parole usate da Phil Jackson per definire la sua ultima stagione sulla panchina dei Chicago Bulls e che danno il nome all’omonimo documentario sulla famosa squadra che negli anni 90 ha fatto la storia dell’NBA. La serie vorrebbe mostrare il culmine del successo di questa squadra di basket ma, anche se in parte lo fa, è più che altro concentrata sulla carriera di Michael Jordan. Certo, nelle prime puntate vengono mostrati due giocatori fondamentali al successo come Scottie Pippen e Dennis Rodman, ma più che altro, grazie ai tanti flash back, è la carriera di Jordan a essere al centro dell’attenzione (anche se viene dato un poco di spazio a elementi del team come Steve Kerr, Tony Kukoc, John Paxon e Horace Grant).
The last dance mostra come i Chicago Bulls e in primis Jordan abbiano avuto negli anni del loro successo una forte impronta non solo a livello sportivo, ma anche mediatico; occorre menzionare che Takehiko Inoue, mangaka e grande appassionato di basket, abbia preso esempio dai Chicago Bulls per disegnare la squadra dello Shohoku in Slam Dunk (vedere la divisa, ma anche la sua storia, dato che, come i Chicago prima dell’avvento di Jordan, questo team era mediocre, divenendo forte a un certo punto con l’arrivo di un paio di elementi fondamentali per la sua crescita), ispirandosi a Jordan e Rodman, sia caratterialmente sia tecnicamente e fisicamente, per creare i personaggi di Kaede Rukawa e Hanamichi Sakuragi. Innegabilmente, i Chicago Bulls e soprattutto Jordan sono stati un brand che ha fruttato milioni di dollari, cambiando radicalmente la NBA (e non solo): è grazie a loro se la più grande e famosa lega di basket ora è quella che è.
Bisogna chiarire però subito una cosa: chi cerca in questo documentario un clinic sulla pallacanestro, che mostri gli schemi, il modo di giocare dei Chicago Bulls, come affrontavano l’avversario, le contromisure che prendevano, può rimanerne deluso, dato che The last dance è più una telenovela o un reality, dove i protagonisti affrontano l’ostacolo di turno, il nemico da battere per raggiungere la meta, mostrandosi da soli contro tutti. Questo, da un certo punto di vista, è anche normale, dato che i Chicago erano divenuti la squadra da battere: è sempre così quando si vince tanto. Questo modo di fare in particolar modo era usato da Jordan, che per caricarsi doveva sempre trovare un nemico da sconfiggere, fossero gli avversari in campo, i media o il general manager Jerry Krause, mostrato in questa serie sotto una luce negativa. Se da un certo punto di vista il carisma di Jordan era capace di guidare la squadra e stimolare i compagni, da un altro punto di vista la grande sicurezza di questo campione sfociava in un ego spesso mostruoso, arrivando a toccare punte di arroganza e bullismo deleterie: avere a che fare con lui non era facile e questo non gli ha procurato grandi amicizie, come lui stesso ha ammesso. Ma era il prezzo da pagare per essere un vincente, questo almeno secondo la sua opinione; ci sono stati altri grandi giocatori nella storia NBA come Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, LeBron James che hanno fatto ugualmente grandi cose senza rendersi così antipatici (senza contare il loro impegno sociale al di là del campo da basket).
Senza dimenticare che Jordan, volente o nolente, è stato preso come un esempio da seguire: l’uomo che ce la fa da solo, che raggiunge la fama e il successo, che non si ferma dinanzi a nessun ostacolo. Insomma, una sorta di superuomo o anche supereroe, idolatrato da una marea di persone. In fondo, chi, non solo tra quelli che giocavano a basket, non ha voluto essere Michael Jordan? Tra i giovani appassionati di pallacanestro, che magari andavano a fare quattro tiri al campetto vicino a casa, non c’è stato uno che non ha sognato di essere il giocatore che portava alla vittoria la propria squadra, il trascinatore, l’uomo della provvidenza che segnava il tiro decisivo all’ultimo secondo. E questo lo si sa per esperienza personale. Anche se può essere un modo antipatico, si comprende la voglia di vincere sempre, in qualsiasi ambito; si comprende questa fame di ottenere risultati, di raggiungere l’obiettivo prefissato, anche se gli altri non lo comprenderanno, anche se gli altri accuseranno che è impossibile stare vicino perché sembra sempre di essere in guerra. A un certo punto occorre fare delle scelte, capire fin dove si può e si vuole arrivare, capire che cosa si può sopportare e che cosa si può diventare: Michael Jordan ha scelto di essere il più grande e questo ha comportato un prezzo da pagare. In quanti avrebbero fatto la sua scelta, avrebbero saputo accettare le conseguenze da essa derivate? Per arrivare al successo spesso si deve sacrificare parte della propria umanità, o per lo meno metterla da parte, dimenticarsene per un periodo che può essere più o meno lungo.
In questo documentario quindi non viene mostrato solo il lato luminoso del grande campione, ma anche le ombre di un uomo che si è trovato a un certo punto a sostenere qualcosa di più grande di lui, che ha messo in piazza le sue debolezze, i suoi vizi, perché questo è il prezzo richiesto dalla notorietà. The last dance risulta perciò un prodotto coinvolgente e convincente, ma non oggettivo, dato che più che altro mostra il punto di vista di Jordan e tutto ruota attorno a lui, anche gli interventi delle altre persone, al punto da essere troppo Jordancentrico: MJ è stato sicuramente uno tra i più grandi campioni di questo sport, e la sua impronta ha condizionato e ha insegnato molto a quelli che sono venuti dopo di lui, ma un campione, per quanto grande, non può fare tutto da solo. Certo, i grandi giocatori possono fare vincere delle partite da soli, ma senza dei compagni all’altezza non si possono vincere i campionati: per questo serve una squadra, un collettivo capace di fare un gioco vincente.
The last dance ha il merito di far conoscere come un simile personaggio abbia condizionato un certo periodo storico e certi comportamenti, sia dentro il campo sia fuori dal campo (chi ha giocato a basket in quel periodo sa di cosa si sta parlando) e perciò merita di essere visto.





.jpg)
.jpg)

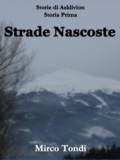







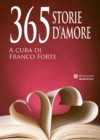





Leave a Reply