«Ehi, Giò.»
Il vecchio si voltò. Marco lo raggiunse e gli diede una pacca sulla spalla. «Ho sentito la grande notizia: domani lascerai questo buco schifoso» disse sorridendo.
«Eh, già» Giò abbozzò un sorriso in risposta.
«Beato te. A me tocca restarci ancora quattro anni, puttanaccia troia» Marco stava per cominciare le solite imprecazioni su come era finito in carcere, quando vide passare a poca distanza da loro Matteo ed Enrico. «Ragazzi, venite a salutare Giò: domani ci lascia.»
«Allora erano vere le voci che circolavano» disse Enrico. «Il gran giorno è giunto.»
«Eh, già» si schermì Giò.
«Non sembri molto felice» fece notare Matteo. «Se vuoi, possiamo fare cambio.»
«Smettila di fare l’asino» lo ammonì Marco. «Giò non vuole mostrare la sua felicità per non farci sentire peggio di come stiamo. Si sente in colpa perché sta per uscire mentre noi dobbiamo restare a marcire qua dentro.»
Sui quattro cadde un silenzio imbarazzato. Enrico fu il primo a riprendere a parlare. «Non devi farlo. Hai saldato il tuo conto: sei in pari con la giustizia.»
«E poi non saresti mai dovuto finire qui dentro: se lo meritava quel figlio di puttana» aggiunse Matteo.
Enrico gli piazzò una gomitata nelle costole.
«Ma che ho detto di sbagliato? È la verità» protestò Matteo risentito.
«Quel che è stato, è stato» disse Giò. «Non ci penso più da tempo.»
«Giusto, bisogna guardare al futuro» Matteo ne approfittò per uscire dalla situazione imbarazzante.
I tre, più giovani di lui di almeno una quarantina d’anni, dopo averlo salutato si recarono nell’area del cortile riservata allo sport. Giò invece andò a sedersi vicino all’angolo delle mura. Scaldandosi le ossa al sole della tiepida giornata autunnale, stette a osservare gli altri detenuti. C’era chi parlava, chi gironzolava senza una meta. Nei loro occhi, nei loro movimenti, vedeva sia noia, sia la tipica energia repressa di chi era rinchiuso in un posto in cui non voleva stare; un tempo era come loro. Ora in lui c’erano calma e accettazione, ma anche malinconia. Se qualcuno, quando era entrato in galera, gli avesse detto che quel posto gli sarebbe mancato il giorno in cui sarebbe uscito, lo avrebbe preso per matto. Anzi, probabilmente gli avrebbe sputato in faccia.
Ma il tempo cambiava le persone. Anche i luoghi in cui si viveva tanto a lungo potevano cambiarle.
Con i ragazzi non era stato sincero: non era vero che non pensava più a quello che era stato, solamente lo vedeva in modo diverso.
Quando era entrato in galera per aver ucciso suo padre, ragionava come Matteo: quell’uomo si meritava quello che gli aveva fatto. Era un ubriacone che costringeva la moglie e i figli a lavorare, restandosene tutto il giorno sul divano a smaltire i postumi di una sbornia in attesa di prenderne un’altra. Aveva accettato per anni quella vita perché altri ragazzi come lui vivevano allo stesso modo; la considerava la normalità. Ma il giorno in cui suo padre, dopo una sbornia più pesante delle altre, aveva cercato di violentare sua sorella, gli aveva piantato un coltello in mezzo alla schiena senza esitare.
Il giudice non aveva preso in considerazione che aveva evitato uno stupro, che erano anni che tutta la famiglia subiva le angherie di quel fallito. Per lui, Giò era solo un violento che andava punito e il fatto che abitasse in un quartiere malfamato di periferia non aveva giocato a suo favore.
A quei tempi aveva provato la rabbia del giusto che si vedeva punito ingiustamente. Ma col trascorrere del tempo, vedendo i suoi anni migliori passare e appassire, la rabbia aveva lasciato il posto al rimpianto.
“Mi sono rovinato la vita per un buono a nulla.” Non faceva che ripetersi. “Avrei dovuto agire diversamente: dovevo solamente stordirlo.”
“Se solo…”
“Se avessi…”
Poi era giunto il momento in cui aveva compreso che macerarsi in quella maniera serviva solo a sprecare ulteriormente la sua vita. Da quell’istante, il ricordo dell’omicidio del padre era servito per dare un senso alla sua esistenza, a non essere un buono a nulla come lui. In carcere aveva imparato a leggere e a scrivere, dato che non era mai potuto andare a scuola; si era fatto un’istruzione. Era diventato qualcuno di rispettato in galera, che aiutava ragazzi come era stato lui a rimettersi in sesto. Da quando era nato, aveva cominciato a sentirsi parte di qualcosa, ad avere un suo posto nel mondo.
E ora quel posto stava per perderlo.
L’indomani sarebbe giunta la fine della sua pena. Aveva smesso di pensarci da così tanto tempo che il suo arrivo era stato improvviso. Quando la guardia carceraria era venuta a riferirglielo, poco c’era mancato che non gli fosse venuto un colpo; per fortuna era seduto sulla branda, altrimenti sarebbe finito col culo per terra.
Tutti si erano felicitati con lui, anche le guardie.
“Ora sei libero” gli dicevano sorridendo. “Ora ricominci a vivere. Ora ti rifai una vita.”
Ma quale vita?
Ormai aveva superato i settant’anni, più di cinquanta trascorsi in galera: che vita poteva esserci per lui oltre le mura del carcere?
Del mondo esterno sapeva quello che leggeva sui giornali, ma come poteva muoversi in una realtà fatta di smartphone, pc, dove tutto era condiviso in rete? Come poteva un vecchio trovare un lavoro? Dove sarebbe andato a vivere?
I parenti che aveva erano morti e non c’era nessuno che potesse prenderlo con sé. Sarebbe vissuto come un barbone, dormendo sui marciapiedi, sulle panchine, al freddo, sotto la pioggia, campando d’elemosina. Isolato e schifato da tutti. Un numero tra i tanti, senza significato, senza una casa.
I suoi occhi si posarono sulle mura, sulla cui sommità il filo spinato luccicava al sole. Poi scivolarono di nuovo sul cortile, per passare successivamente sulla parete dell’edificio alle sue spalle.
Il carcere era la sua casa. Qui sapeva come muoversi, cosa aspettarsi. Qui aveva degli amici.
Fuori non aveva nessuno.
Fuori non era nessuno.
L’ora d’aria finì e lentamente si unì agli altri per rientrare.
Quella sera a cena ci fu un brindisi in suo onore. Un brindisi povero, dato che avevano solo acqua, ma sincero. Ringraziò tutti con cenni del capo e delle mani, senza dire una parola, perché sapeva che se lo avesse fatto si sarebbe messo a piangere.
Venne il momento di tornare in cella. Le luci si spensero, le voci si acquietarono.
Giò si sedette sul letto. Carezzò le sbarre. Poi si alzò e passò la mano sulle pareti scrostate. Raggiunse la finestra inferriata e fissò la luna.
Le lacrime che era riuscito a trattenere fino allora presero a scorrere sulle guance.
«Questo è l’unico posto che conosco, Signore» singhiozzò. «Non farmi andare via: non ho dove altro stare. Qui ho un tetto sulla testa, un letto in cui dormire, una tavola cui sedermi a mangiare. Là fuori non c’è nulla per me. Ti prego, fammi restare, non voglio morire di stenti in un luogo sconosciuto, dove nessuno sa il mio nome.»
Quando la mattina le guardie vennero a prenderlo, lo trovarono disteso come sempre nel suo letto.
«Giò, il gran giorno è arrivato» disse la prima guardia aprendo la sua cella.
«La libertà ti aspetta, Giò: hai tutto il mondo davanti» aggiunse la seconda guardia con allegria.
Non avendo risposta, lo scossero, senza ottenere alcuna reazione.
La prima guardia posò due dita sul collo del vecchio. «Poveraccio» mormorò costatando che era morto.
«Almeno se n’è andato felice» disse la seconda guardia fissando il lieve sorriso disegnato sul suo volto.
Se quelle fredde labbra avessero potuto ancora muoversi, gli avrebbero dato ragione, ma non per i motivi che credeva.





.jpg)
.jpg)

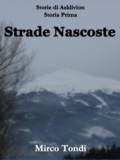







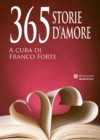





Leave a Reply