Carlo guardò le auto della polizia parcheggiate davanti alla casa. Con calma diede un tiro alla sigaretta, assaporando il fumo che entrava nei polmoni.
Luigi fu il primo a essere portato fuori: lui, che camminava sempre a testa alta tra la gente, ora stava a capo chino, gli occhi inchiodati sul marciapiede.
“Ti vantavi sempre di saperci fare con le parole: perché non fai uno dei tuoi bei discorsi?”
Ma Luigi se ne stava muto, le mani ammanettate dietro la schiena, facendosi condurre come un bambino ubbidiente.
Dietro di lui Francesca piangeva, dimenandosi come una pazza tra le braccia di due agenti.
Carlo la scrutò intensamente. “Sorridi, che la vita ti sorride: non è così che mi dicesti quella volta? Perché tutte queste lacrime?” Diede un altro tiro alla sigaretta. “Non è così facile sorridere quando si è nella merda, vero brutta stronza?”
Pochi secondi dopo comparve Gianfranco, pallido in volto, quasi trasportato di peso da due poliziotti.
“Oibò, fenomeno, ora non fai più tanto lo sborone.”
Dalla casa giunsero urla isteriche che crebbero d’intensità. Pamela era una donna minuta, ma ci vollero tre poliziotti per trascinarla fuori dalla porta.
«Ridatemi mio figlio! Ridatemi mio figlio!» si sgolava inarcandosi, cercando di guardare dietro di sé.
Quando fu fatta salire su una delle auto della polizia, un agente uscì nel cortile tenendo tra le braccia, avvolto in delle coperte, un infante che piangeva disperato.
Una smorfia contrasse il volto di Carlo: non riusciva a sopportare i pianti dei bambini. “Mi spiace per quello che stai passando, piccolino, tu non c’entri nulla; verrai tolto a tua madre, è inevitabile dopo questa notte, ma fidati di me: è molto meglio così. Tu ancora non sai che razza di persona è. Ma se sei fortunato, non lo saprai mai.”
Osservò le auto con a bordo i suoi ex compagni di classe allontanarsi lungo la strada. Non più rotta dalle urla di Pamela, la notte era tornata quieta. Seduto sulla panchina, Carlo ascoltò lo sciabordio del fiume che scorreva alle sue spalle. Con la mente tornò a un giorno di scuola di dieci anni prima.
Non sapeva se fosse stata un’idea di tutti e quattro o solo di alcuni di loro. Forse era stato uno solo ad averla: non importava. Quello che sapeva per certo è che loro facevano tutto insieme, si coprivano sempre a vicenda, anche quando facevano qualcosa di sbagliato.
«È stato solo uno scherzo» gli ripetevano tutte le volte che lo incontravano da solo, ammettendo così la responsabilità del fatto. «Non devi prendertela.»
Quello che per loro era stato uno scherzo, per lui era stata la rovina della vita.
Il padre, quando aveva saputo quello che era accaduto, lo aveva pestato di brutto. Aveva provato a difendersi, ma pugni e calci piovevano da tutte le parti. L’ultima cosa che si ricordava erano lo zio e il nonno che portavano via di peso suo padre che urlava come impazzito «Lo ammazzo! Lo ammazzo!» Si era risvegliato all’ospedale intubato, un braccio ingessato; al suo fianco c’era sua madre con gli occhi gonfi di pianto che gli teneva la mano. «Andrà tutto bene» gli ripeteva.
Ma le cose non erano andate per niente bene.
Dopo quanto accaduto, i suoi divorziarono: sua madre non voleva più che suo padre avesse a che fare con loro. Si erano trasferiti in un’altra città, dove potevano cominciare una nuova vita. Ma sapeva che questo non era possibile: certe etichette non vengono più via. Quello che più lo feriva però era sua madre quando lo guardava. A parole non faceva che ripetere che il tempo avrebbe sistemato le cose, che tutto sarebbe andato bene, ma negli occhi leggeva la perdita di fiducia nei suoi riguardi.
E tutto perché quei quattro bastardi gli avevano infilato un sacchettino di marjuana in mezzo al quaderno dei compiti che, guarda caso, la professoressa d’italiano proprio quel giorno avrebbe ritirato. Solitamente il controllo lo avrebbe fatto a casa, con calma, ma quella mattina aveva deciso di fare una cosa veloce in classe; quando vide il sacchettino, reagì da isterica.
«Tu sei un drogato» sibilò sconvolta prima di uscire di corsa dall’aula. Poco dopo arrivò la polizia che lo prelevò per portarlo in caserma. Passando per i corridoi aveva addosso gli occhi degli studenti e dei professori delle altre classi.
Vista la quantità di roba trovatagli nel quaderno, se l’era cavata con poco, ma sarebbe stato tenuto d’occhio: questo gli disse il carabiniere che lo accompagnò a casa.
La scuola divenne un inferno. Tanti nel suo istituto facevano uso di marjuana e robe più pesanti, ma lui era diventato “il drogato”: così ormai tutti lo chiamavano. I professori non fecero nulla per aiutarlo: alcuni vedevano come veniva trattato, ma facevano finta di non vedere; altri lo presero di mira, trattandolo peggio dei coetanei.
Fu un sollievo quando cambiò scuola. Ormai però era stato marchiato.
Osservò due poliziotti uscire dalla casa: uno teneva al guinzaglio un cane antidroga, l’altro teneva in mano un sacchetto di plastica trasparente con all’interno qualcosa di bianco. Poi chiusero la porta e misero i sigilli per indicare che l’edificio era sotto sequestro.
Carlo rimase seduto ancora un poco sulla panchina. Fumò un’altra sigaretta. Poi si alzò e si allontanò nella notte, un lieve sorriso sulle labbra.
Come scriveva Stephen King, prima o poi, per ogni cane il giorno buono arriva.





.jpg)
.jpg)

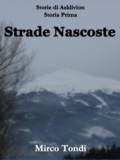







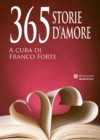





Leave a Reply