Secondo racconto con cui ho partecipato al Mezzogiorno d’Inchiostro numero 100 di Writer’s Dream. Questa volta la traccia che ho deciso di seguire tra le due a disposizione è stata Sliding doors – il destino. In questo caso occorreva realizzare un testo in cui il destino la fa da padrone o in cui il protagonista riesce a raggirarlo: ecco come ho affrontato il tema.
«I figli di operai non si devono permettere di andare meglio degli altri. Ai figli di operai non dovrebbe essere permesso nemmeno di andare a scuola.»
Questo mi disse quel figlietto di papà prima di colpirmi in faccia con un pugno. Incassai senza fiatare. Avrei potuto tranquillamente evitare il colpo. Avrei potuto stenderlo con facilità: ero più forte, più resistente, il mio fisico temprato dai duri lavori. Lui, solo per aver dato un pugno, aveva già il fiatone: non era abituato alla fatica, allo sforzo fisico. Aveva tutto e l’aveva ottenuto semplicemente chiedendo, non si era mai dovuto impegnare, non aveva mai dovuto sudare, fare sacrifici. Non valeva un decimo di me. Eppure lo lasciai colpire. Non fu codardia la mia, solo buon senso. Quelli come lui erano dei codardi; infatti si era portato con sé sei amici. Ne avrei potuti battere due, tre, ma poi le avrei prese e pure di brutto, quindi cercai di limitare i danni. Me la cavai con un occhio nero.
Il gruppo di ragazzi che ho davanti se ne va alla svelta; ho riconosciuto subito cosa sono. Ogni tanto si voltano, lanciando qualche rapido sguardo, ma subito tornano a guardare avanti. Allungano il passo. Hanno paura di quelli come me, perché non sanno a cosa possono andare incontro, non sanno se nascondiamo qualcosa sotto i nostri abiti, se siamo degli squilibrati. Passano gli anni ma certe cose non cambiano: i figlietti di papà sono sempre dei codardi. Sembra quasi che si adeguino a un copione già scritto, seguendo delle direttive fatte apposta per loro, come se non potessero scegliere diversamente.
La mancanza di scelte. Ho sempre ritenuto idiota questa cosa: c’è sempre possibilità di scelta. Ma chissà perché sono così in pochi a capirlo.
Obblighi. Morale. Pare che in molti vogliano far percorrere strade già preparate e conosciute: qualcosa di diverso per loro è inconcepibile.
Anche mio padre apparteneva a questa categoria: per lui dovevo fare la sua stessa vita. Non è riuscito (o non ha voluto) finire le medie, quindi si aspettava che io facessi lo stesso: per lui era una cosa normale, anzi dovuta, dato che nessuno nella sua famiglia è mai andato oltre quel livello. Ogni anno scolastico passavano a stento con la sufficienza, quando non erano bocciati, tirando avanti fino a raggiungere l’età per andare a lavorare. Per loro avere un lavoro era tutto quello che si poteva ottenere dalla vita. Guadagnare soldi per poi spenderli al bar, in discoteca, comprare un motorino, poi un’auto; poi trovare una e mettere su famiglia: questo era tutto quello che per loro la vita aveva da dare. Questo doveva valere anche per me. Sono passato tutti gli anni con il massimo dei voti. Mi sono laureato. Questo non gli è mai andato giù; non sono mai riusciti ad accettare che fossi più in gamba di loro. Non me l’hanno mai perdonato, hanno cercato di ostacolarmi in ogni modo; non ci sono riusciti. Avrei dovuto odiarli, disprezzarli; li ho solo compatiti. Poi li ho lasciati perdere.
A un certo punto diventa anche divertente scombinare le aspettative, i piani che gli altri hanno per noi. Come ho fatto con la mia maestra delle elementari: era una patita della poesia e pretendeva che lo fossero anche i suoi alunni. Io da piccolo ero esuberante, scalmanato, com’è normale che sia per un bambino: quello che allora m’interessava era correre dietro un pallone. Lo facevo tutte le volte che potevo e non facevo altro che pensare a quando avrei fatto la prossima partita di calcio. Inutile dire che non m’importava nulla della poesia. Questo alla maestra non andava giù.
«Gli sportivi sono dei violenti. Tu sei un violento: prima dei diciotto anni sarai in galera» mi ripeteva in continuazione. «A correre sempre dietro un pallone non imparerai mai a scrivere e a parlare in italiano.»
Poveretta, non capiva che quella davvero violenta era lei: ogni volta che pronunciava quelle parole così rancorose mi aspettavo che le venisse la bava alla bocca. Morì pochi anni dopo per un infarto; se fosse ancora viva penso che schiumerebbe rabbia sapendo che nei quaranta e passa anni della mia vita non ho mai preso una multa; senza contare che ho pubblicato due libri e tenuto decine di seminari. Alla faccia di quello che non doveva saper scrivere e parlare in italiano.
Sono stato tante persone e di me si è detto di tutto, sempre una cosa diversa, ma c’è una costante: ho sempre scombinato i progetti secondo i quali, per gli altri, io ero destinato.
Destino. Una parola per gente limitata, per chi non ha coraggio. Un termine usato da chi vuole condizionare e sfruttare gli altri.
Non credo al destino. Credo nelle capacità personali. Credo nelle possibilità e nell’opportunità di poterle cogliere. O non cogliere. Ogni porta che si apre o si chiude conduce a strade che possono farci cambiare ed essere diversi, magari migliori di quello che eravamo o potevamo essere.

Anni fa potevo diventare un dirigente, un capitano d’industria; per quello che era il mio capo allora, ero destinato al successo, a divenire ricco e potente. Non mi piacque quello che potevo diventare. Ad andare con lo zoppo s’impara a zoppicare e io non volevo divenire come gli esempi che avevo davanti: individui che trattavano in malo modo gli altri e li facevano soffrire.
«Così va il mondo: c’è chi è destinato a comandare, chi a obbedire» mi disse il mio capo.
«Devi accettare i compiti che la nuova mansione richiede. Potrà non piacerti, ma tutti dobbiamo fare sacrifici. Che razza di destino vuoi far vivere ai nostri futuri figli? Vuoi che siano degli stupidi figli di operai?» mi disse la mia fidanzata.
Destino. Destino. Non mi piacquero quei discorsi. Non mi piacque il tono con cui furono pronunciati. Non mi piacque il loro senso e quello che in essi era nascosto ma che per me era evidente.
Mi licenziai. Lasciai la mia fidanzata.
Non fu solo quello: mollai tutto quello che avevo e gli voltai le spalle.
Per molti sono un pazzo. O un fallito. Non ho più un posto dove tornare. Non ho più un ruolo in società. Sono sempre in viaggio, non dormo mai nello stesso posto. Questo a tanti spaventerebbe, ma per me anche vivere sotto un ponte è qualcosa di bello; è difficile spiegare il senso di leggerezza che provo. A parte me stesso non ho nulla, ma sono libero e non devo niente a nessuno. E questo per me è tutto.





.jpg)
.jpg)

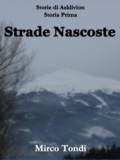







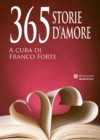





Un po’ paleocomunista ma bello.
Paleocomunista non lo conoscevo come termine (c’è sempre qualcosa da imparare 🙂 ). Grazie 🙂